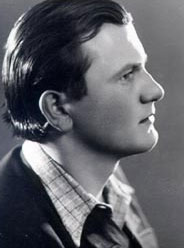Karol Wojtyla, il poeta che un giorno diventò Papa
Il 2 aprile 2008 cade il terzo anniversario della scomparsa di Giovanni Paolo II e la nostra rivista ha deciso di tributargli un piccolo omaggio centrando però l’attenzione non sul pontefice, del quale praticamente si sa ogni cosa, essendo stati versati fino ad oggi molti fiumi di inchiostro sulla sua persona e sul suo pontificato, ma sul poeta Wojtyla, assai meno noto, e che pure merita di essere analizzato e di poter uscire dall’oblio della disattenzione, ora che la morte e la distanza temporale concedono quegli spazi che sono necessari alla riflessione critica e al dibattito letterario.
 “Cogliere la trama infinita di nessi col mistero dell’esistenza umana”: sarebbe questo il segreto dei versi di Karol Wojtyla (1920-2005), la loro precisa cifra poetica, per il gesuita Antonio Spadaro, autorevole scrittore de La Civiltà Cattolica e grande conoscitore della poesia di quell’autore polacco salito un giorno di trent’anni fa al soglio di Pietro col nome di Giovanni Paolo II.
“Cogliere la trama infinita di nessi col mistero dell’esistenza umana”: sarebbe questo il segreto dei versi di Karol Wojtyla (1920-2005), la loro precisa cifra poetica, per il gesuita Antonio Spadaro, autorevole scrittore de La Civiltà Cattolica e grande conoscitore della poesia di quell’autore polacco salito un giorno di trent’anni fa al soglio di Pietro col nome di Giovanni Paolo II.
“Leggere la poesia di Karol Wojtyla – ha detto ancora Spadaro – significa compiere un percorso che coinvolge pienamente l’esistenza a livello estetico ed emozionale fino a toccare le corde più profonde del significato dell’esperienza umana”. Un percorso da egli ben esplicitato nel saggio “Nella melodia della Terra. La poesia di Karol Wojtyla” (Jaca Book 2006) che, va subito detto, rappresenta la pietra miliare, la base essenziale da cui partire, per ognuno che voglia comprendere le coordinate poetico-esistenziali del Wojtyla autore di versi.
La personalità poetica di Karol Wojtyla, come spiega efficacemente nelle pagine seguenti Rosa Elisa Giangoia, è stata scoperta con lentezza e gradualità dal pubblico, in quanto offuscata dalla luminosità della sua figura di Pontefice e resa problematica dalla difficoltà (fino ad almeno una decina di anni fa) di leggere in italiano i suoi testi poetici, pubblicati fin dalla lontana giovinezza dell’autore con continuità, ma in polacco e per lo più con pseudonimi.
 “Cosa stai facendo? Vuoi sprecare il tuo talento?”. Il professor Kotlarczyk, suo insegnante di lingua polacca nel ginnasio di Wadowice, col quale avrebbe poi dato vita al Teatro Rapsodico, se l’era un po’ presa quando il suo brillantissimo allievo gli aveva comunicato la decisione di farsi prete. Il giovane Lolek, infatti, era un ottimo poeta, e tale sarebbe rimasto nello scorrere degli anni, malgrado la vita con i suoi snodi repentini e segreti l’avesse condotto lontano.
“Cosa stai facendo? Vuoi sprecare il tuo talento?”. Il professor Kotlarczyk, suo insegnante di lingua polacca nel ginnasio di Wadowice, col quale avrebbe poi dato vita al Teatro Rapsodico, se l’era un po’ presa quando il suo brillantissimo allievo gli aveva comunicato la decisione di farsi prete. Il giovane Lolek, infatti, era un ottimo poeta, e tale sarebbe rimasto nello scorrere degli anni, malgrado la vita con i suoi snodi repentini e segreti l’avesse condotto lontano.
Nel 1934, a soli 14 anni aveva vinto un premio nella gara di lettura di un poema filosofico di Cyprian Norwid, autore polacco tra i suoi più amati. Da lì in poi si sarebbe dedicato allo studio dei classici della sua terra per iscriversi, nel 1938, al corso di Filologia polacca, presso l’Università di Cracovia. La successiva scelta di diventare sacerdote non lo avrebbe però distolto dalla poesia. L’anno seguente infatti Wojtyla partecipa a “Studio 39”, gruppo di amici con la passione del teatro e della letteratura, maturando sempre più la percezione di un’arte intesa non tanto come “gioco” ma piuttosto come “sguardo”.
Nel 1946, anno della sua ordinazione sacerdotale, pubblicò la sua prima opera compiuta, “Canto del Dio nascosto”, scritto durante gli anni del seminario clandestino. Qui il 26enne Karol fissa il suo proposito, che è al tempo stesso esistenziale e poetico, da cui non si sarebbe mai allontanato: “Devi fermarti a guardare – scrive nel “Canto” – sempre più in profondità / finché non riuscirai a distogliere l’anima dal fondo. Là nessun verde sazierà la vista”.
Sono le poesie della maturità che si collocano nel ventennio 1946-1966 e in cui vengono filtrate a poco a poco l’ispirazione da San Giovanni della Croce, insieme alla lezione di Dante, di John Donne e di T.S. Eliot. Il bellissimo poemetto “La cava di pietra” è del 1957. Wojtyla aveva conosciuto piuttosto bene il lavoro pesante, perché dal 1939 al 1944 per evitare la deportazione aveva lavorato assai duramente come operaio prima nelle cave, e poi nelle industrie chimiche Solvay, presso Cracovia.
Un ‘esperienza che l’aveva segnato fortemente, e che in seguito rivive nei versi del poemetto dove il lavoro da dura realtà esistenziale si fa anche metafora di un serrato contrappunto tra la grandezza del lavoro stesso e l’ineludibile dignità di ogni essere umano: “Ascolta, una scarica elettrica taglia il fiume di pietra, / e in me cresce un pensiero, di giorno in giorno: / che la grandezza del lavoro è dentro l’uomo”.
Un altro tema ricorrente della sua poesia riguarda il rapporto con Cristo. Quattro mesi prima di divenire vescovo di Cracovia, nel marzo 1958, veniva pubblicato il poema “Profili di Cireneo”, una “fenomenologia poetica dell’uomo contemporaneo”, come la definisce Antonio Spadaro nel suo saggio, dove Karol Wojtyla tratteggia in piccoli quadri 14 profili di “cirenei” di oggi: il melanconico, l’intellettuale, l’attore, la ragazza delusa in amore, gli operai… E ciascun profilo è quello di un cireneo che ha un suo personale giogo da portare sulle spalle e tutti, scrive, “si aggirano ai confini di Dio”.
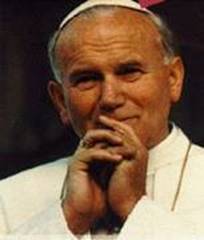 Operaio, minatore, filosofo, patriota, attore ed anche poeta. Questo è il Karol Wojtyla che diventerà un giorno Arcivescovo di Cracovia, approdando al conclave del 1978 da cui uscirà Papa. Ma della sua attività di poeta ben pochi sono al corrente, perché i suoi testi sono pubblicati di volta in volta sotto vari pseudonimi, fra cui quello di Andrzej Jawien, con il quale pubblica anche il dramma “La bottega dell’orefice” (del 1960), il capolavoro che gli italiani scopriranno nella versione radiofonica approntata dalla RAI nei mesi successivi alla sua elezione al soglio di Pietro.
Operaio, minatore, filosofo, patriota, attore ed anche poeta. Questo è il Karol Wojtyla che diventerà un giorno Arcivescovo di Cracovia, approdando al conclave del 1978 da cui uscirà Papa. Ma della sua attività di poeta ben pochi sono al corrente, perché i suoi testi sono pubblicati di volta in volta sotto vari pseudonimi, fra cui quello di Andrzej Jawien, con il quale pubblica anche il dramma “La bottega dell’orefice” (del 1960), il capolavoro che gli italiani scopriranno nella versione radiofonica approntata dalla RAI nei mesi successivi alla sua elezione al soglio di Pietro.
E’ solo con l’ascesa al soglio pontificio, infatti, che il suo “segreto” venne svelato. Fatta eccezione infatti per le letture poetiche nel periodo prima della guerra, Wojtyla non aveva mai presentato in pubblico le sue poesie. Quelle giovanili soprattutto, degli anni 1938-39 per intenderci, sono rimaste nascoste per circa un cinquantennio, e per esplicita volontà del loro autore.
Subito tradotto dalla Libreria Editrice Vaticana, il testo de “La bottega dell’orefice” rappresenta l’inizio per così dire ufficiale della vicende editoriali italiane del “papa poeta”, dopo la pubblicazione di “Profili del Cireneo” presso le Edizioni Gr di Besana Brianza (1978). Ancora nel 1979 escono le raccolte di versi “Pietra di luce” e “Il sapore del pane”, alla cui versione contribuisce in modo determinante la poetessa Margherita Guidacci (per i tipi della Libreria Editrice Vaticana). Nel 1982, per lo stesso editore, escono anche i drammi “Giobbe”, “Raggi di paternità” e “Fratello del nostro Dio”, portato quest’ultimo sullo schermo da Krzysztof Zanussi nel 1997 (mentre la versione cinematografica della “Bottega dell’orefice”, per la regia di Michael Anderson, è datata 1988).
La prima raccolta complessiva delle “Opere letterarie” del Pontefice viene approntata nel 1993 dalla Libreria Editrice Vaticana e parzialmente riproposta in edizione economica, limitatamente alle sole “Poesie”, da Newton Compton l’anno successivo. La sua “opera omnia” attualmente è quella edita da Bompiani nel 2001, nel volume “Tutte le opere letterarie” di Karol Wojtyla, che rappresenta indubbiamente uno strumento indispensabile per conoscere l’intera opera poetica di Giovanni Paolo II. Un migliaio di pagine con drammi e poesie (testo originale a fronte), più un ampio saggio di Giovanni Reale e dettagliate schede introduttive alle singole opere a cura di Boleslaw Taborski. Più recente l’arrivo in libreria delle “Poesie giovanili: Cracovia, primavera estate-1939” a cura di Marta Burghardt (edito da Studium).
Karol Wojtyla ci ha lasciato un’opera letteraria composta complessivamente da varie raccolte poetiche e cinque drammi. Sono costitutive della sua espressione poetica le ballate epiche, appassionati canti alla patria polacca, assorte meditazioni religiose, prose poetiche o poesie narrative che dir si voglia, originali intuizioni liriche che esprimono in lui una profonda “devozione alla parola” intesa come “elemento di natura morale”.
A noi piace ricordare i versi splendidi, indimenticabili, con cui Wojtyla rievocava, appena ventenne, la figura della madre Emilia, dolorosamente perduta alla tenera età di 9 anni, e mai dimenticata:
”Sulla tua bianca tomba
sbocciano i fiori bianchi della vita.
Quanti anni sono già spariti senza di te.
Quanti?
Sulla tua bianca tomba,
ormai chiusa da anni,
qualcosa sembra sollevarsi:
inesplicabile come la morte.
Sulla tua bianca tomba,
madre, amore mio spento,
dal mio amore filiale, una prece”.
Sono versi semplici e accorati scritti quasi agli albori della vita, che fanno pendant con quelli della vecchiaia, che Wojtyla – quasi prefigurando il suo congedo dal mondo – ha un giorno riunito nel “Trittico romano”, edito nel 2003 dalla Libreria Editrice Vaticana con la traduzione di Grazyna Miller.
Nell’ultima raccolta di versi, lo sguardo del poeta si colloca all’ingresso della Cappella Sistina, dove la visione è quella del Giudizio: qui l’Inizio si congiunge con la Fine. Lasciandosi avvolgere dalla “policromia sistina”, Karol Wojtyla ricorda i due conclavi da lui vissuti ed immagina il momento della sua morte e il successivo conclave, da cui uscirà il nuovo Pietro.
Leggiamo:
E proprio qui, ai piedi di questa stupenda policromia sistina,
si riuniscono i cardinali –
una comunità responsabile per il lascito delle chiavi del Regno.
Giunge proprio qui.
E Michelangelo li avvolge, tuttora, della sua visione.
“In Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo… ”
Chi è Lui?
Ecco, la mano creatrice dell’Onnipotente Vecchio, diretta verso Adamo…
Al principio Dio ha creato…
Costui che vede tutto…
La policromia sistina allora propagherà la Parola del Signore:
Tu es Petrus – udì Simone, il figlio di Giona.
“A te consegnerò le chiavi del Regno”.
La stirpe, a cui è stata affidata la tutela del lascito delle chiavi,
si riunisce qui, lasciandosi circondare dalla policromia sistina,
da questa visione che Michelangelo ci ha lasciato –
Era così nell’agosto e poi nell’ottobre, del memorabile anno dei due conclavi,
e così sarà ancora, quando se ne presenterà l’esigenza dopo la mia morte.
All’uopo, bisogna che a loro parli la visione di Michelangelo.
“Conclave”: una compartecipata premura del lascito delle chiavi, delle chiavi del Regno.
Ecco, si vedono tra il Principio e la Fine,
tra il Giorno della Creazione e il Giorno del Giudizio.
È dato all’uomo di morire una volta sola e poi il Giudizio!
Una finale trasparenza e luce.
La trasparenza degli eventi –
La trasparenza delle coscienze –
Bisogna che, in occasione del conclave, Michelangelo insegni al popolo –
Non dimenticate: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius.
Tu che penetri tutto – indica!
Lui additerà…
Come assai acutamente scriveva allora il cardinale Joseph Ratzinger nel commento all’ultimo testo poetico di Giovanni Paolo II, il quale solamente due anni dopo si sarebbe congedato dal mondo per cedere proprio a lui, suo “amico fidato”, il testimone sul soglio di Pietro: “Nelle immagini del mondo, Michelangelo ha scorto la visione di Dio; egli ha, per così dire, visto con lo sguardo creatore di Dio e, attraverso questo sguardo, ha riportato su muro, per mezzo di audaci affreschi, la visione originale dalla quale deriva ogni realtà.
In Michelangelo, che ci aiuta a riscoprire la visione di Dio nelle immagini del mondo, sembra realizzarsi in modo esemplare ciò che è destinato a tutti noi. Di Adamo ed Eva, che rappresentano l’essere umano in generale, uomo e donna, il Papa dice: ‘Anche loro sono divenuti partecipanti di questa visione…’. Ogni uomo è chiamato a ‘riacquistare questa visione di nuovo’. Il cammino che conduce alla sorgente – spiega allora Ratzinger, oggi papa Benedetto XVI – è un cammino per diventare vedenti: per imparare da Dio a vedere. Allora appaiono il principio e la fine”.
Rassegna Stampa
Gallagher: Ho incontrato un popolo ferito e coraggioso, serve dialogo per la pace
Intervista con l’arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati a conclusione della sua missione in Ucraina
Kiev, anche sotto le bombe di Putin la «fabbrica dei bambini» fa affari
«Questa guerra non ha fermato Biotexcom»