Conferenza data da Armand Veilleux all’Università Regina Apostolorum, a Roma, il 5 dicembre 2000
La testimonianza dei Martiri di Tibhirine
Conferenza data da Armand Veilleux all’Università Regina Apostolorum, a Roma, il 5 dicembre 2000, durante un Simposio sui Martiri dell’Africa e dell’Asia.
Dio è amore. Dio è Comunione. La salvezza è partecipazione all’intimità della vita di comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cristo è il testimone fedele (ho mártus ho pistós), il martire per eccellenza, il sacramento primordiale della salvezza, perché egli è la manifestazione visibile del disegno salvifico del Padre su tutta l’umanità. A sua volta, la Chiesa è sacramento di Cristo, perché anch’essa è la manifestazione visibile della stessa realtà di salvezza attraverso il segno della comunione tra gli uomini nella stessa fede, nella stessa speranza e nello stesso amore.
La morte di Cristo non è stata un atto isolato. È stato il momento culminante di tutta la sua vita. Così è anche per la vita e la morte dei suoi discepoli, chiamati a dare testimonianza attraverso tutta la loro vita. E vengono chiamati “martiri” coloro che hanno accettato di subire una morte violenta piuttosto che mancare di fedeltà alla testimonianza che avevano reso durante tutta la vita. È quindi innanzi tutto attraverso la propria vita – vissuta fino in fondo – che un cristiano è martire.
In Africa, ai tempi di Tertulliano e di Cipriano, la Chiesa ha avuto una grande corona di martiri. E di nuovo, negli ultimi decenni, nell’Africa del Nord numerosi testimoni di Cristo hanno subito una morte violenta come logica continuazione e conseguenza della loro vita di comunione in nome del Vangelo. Molti di loro non hanno lasciato tracce sulla stampa e restano noti a Dio solo. Per altri, la morte è stata un evento pubblico ed ha richiamato l’attenzione. Tra tutti coloro che in Algeria hanno reso testimonianza fino alla morte, nel corso degli ultimi sette anni, i sette monaci trappisti di Tibhirine sono probabilmente quelli che hanno maggiormente richiamato l’attenzione e che hanno ricevuto la più grande manifestazione di affetto e di interessamento. Ma prima di loro, nella diocesi di Algeri, erano morti nell’esercizio del loro ministero di comunione altri undici ministri del Vangelo. Dopo di loro, ci fu un altro grande testimone della fede, il vescovo di Orano, Pierre Claverie.
La mia comunicazione di oggi verte essenzialmente sulla testimonianza dei sette monaci di Tibhirine, miei confratelli nell’Ordine cistercense, che ho avuto la grazia di conoscere personalmente. Vorrei tuttavia dire qualche parola anche sugli altri martiri della chiesa di Algeria dello stesso periodo, e descrivere il contesto in cui tutti questi testimoni sono stati indotti a versare il loro sangue.
Martiri in terra d’Algeria negli anni novanta.
~ L’8 maggio 1994, Suor Paule-Hélène Saint-Raymond e Fratel Henri Vergès venivano assassinati nella biblioteca che avevano organizzato per i giovani di un quartiere popolare di Algeri.
~ Il 23 ottobre dello stesso anno, Suor Esther Paniagua e Suor Caridad María Alvarez vennero uccise davanti alla cappella di Bab-el-Oued.
~ Il 27 dicembre – sempre dello stesso anno — quattro Padri Bianchi furono assassinati nella loro casa, a Tizi-Ouzou : erano Padre Alain Dieulangard, Charles Deckers, Jean Chevillard e Christian Chessel.
~ Il 3 settembre 1995, Suor Denise Leclercq e Soeur Jeanne Littlejohn furono colpite a morte a Belcourt da due pallottole alla testa.
~ Infine, il 10 novembre 1995, Suor Odette Prévost venne uccisa e Suor Chantal Galicher restò ferita sulla soglia del loro domicilio, nel quartiere di Kouba.
In queste morti, si possono rilevare alcune costanti. Tutti questi testimoni erano persone che avevano stabilito dei legami di amicizia con il popolo algerino e vivevano in una grande comunione con la gente comune, di cui condividevano la vita. Tutti sono stati uccisi nell’ambiente in cui vivevano e lavoravano. Il messaggio dei loro assassini – o dei loro mandanti – è chiaro : erano proprio questa prossimità e fraternità ciò che disturbava e si voleva far cessare. Non si rimproverava loro di fare del proselitismo, perché non lo facevano. Li si accusava di essere persone di comunione, che condannavano con la loro stessa vita qualsiasi forma di esclusione e ogni forma di violenza, da qualunque parte venisse, quale che fosse la matrice o l’ideale – religioso o politico – di provenienza. Nessuno di loro faceva politica. Nessuno aveva preso posizione nelle controversie che opponevano diverse fazioni della società algerina. E tuttavia la loro vita aveva una dimensione politica: lavoravano alla costruzione della comunità algerina. Per la loro nazionalità e la loro religione, appartenevano a una piccola minoranza. La loro presenza in Algeria affermava, contro tutte le forme di esclusione e di sradicamento dell’altro, il diritto alla differenza.
Nessuno di loro era un operatore solitario, che lavorasse da solo e in modo marginale. Tutti e tutte erano persone di comunità, e vivevano la loro vita cristiana e religiosa in piccole comunità, figli e figlie fedeli di quella grande comunità che è la Chiesa, amanti della grande comunità umana, senza alcun esclusivismo. Tutti incarnavano il tipo di presenza cristiana in terra d’Algeria che aveva instaurato quel grande Vescovo di Algeri che era stato il Cardinale Duval.
 Il Cardinale Duval. Quest’ultimo, chiamato a presiedere l’Archidiocesi di Algeri verso la fine del periodo coloniale – quando nulla sembrava averlo preparato a una situazione così complessa, si era rivelato la persona giusta per quel momento storico. Durante la guerra di indipendenza, si fece rispettare da tutti, ad eccezione degli estremisti di una parte come dell’altra, affermando la fede che egli aveva nella possibilità data a tutti di vivere come fratelli e condannando esplicitamente e ripetutamente la violenza – tutte le forme di violenza, da qualsiasi parte provenissero. Era una presa di posizione estremamente pericolosa, ed è un miracolo che non sia mai stato eliminato. Il Signore ha voluto che egli restasse, fino ad età avanzata e molto tempo dopo aver lasciato le sue funzioni ufficiali, come testimone fedele di questo tipo di testimonianza cristiana. Quelli che sono morti martiri in questi ultimi anni sono coloro che hanno vissuto nel miglior modo la testimonianza che egli stesso aveva dato durante il suo episcopato. Ed egli la visse perfino nella sua morte, perché la causa immediata del suo decesso fu, realmente, il dolore profondo che gli causò l’apparente fallimento della convivenza e della fraternità universale che egli aveva desiderato per l’Algeria.
Il Cardinale Duval. Quest’ultimo, chiamato a presiedere l’Archidiocesi di Algeri verso la fine del periodo coloniale – quando nulla sembrava averlo preparato a una situazione così complessa, si era rivelato la persona giusta per quel momento storico. Durante la guerra di indipendenza, si fece rispettare da tutti, ad eccezione degli estremisti di una parte come dell’altra, affermando la fede che egli aveva nella possibilità data a tutti di vivere come fratelli e condannando esplicitamente e ripetutamente la violenza – tutte le forme di violenza, da qualsiasi parte provenissero. Era una presa di posizione estremamente pericolosa, ed è un miracolo che non sia mai stato eliminato. Il Signore ha voluto che egli restasse, fino ad età avanzata e molto tempo dopo aver lasciato le sue funzioni ufficiali, come testimone fedele di questo tipo di testimonianza cristiana. Quelli che sono morti martiri in questi ultimi anni sono coloro che hanno vissuto nel miglior modo la testimonianza che egli stesso aveva dato durante il suo episcopato. Ed egli la visse perfino nella sua morte, perché la causa immediata del suo decesso fu, realmente, il dolore profondo che gli causò l’apparente fallimento della convivenza e della fraternità universale che egli aveva desiderato per l’Algeria.
Tutti i religiosi e le religiose di cui ho menzionato il martirio sono morti prima dei sette monaci di Tibhirine. Un altro grande testimone della fede – un discepolo e un fedele amico del Cardinal Duval – è morto poco dopo di loro, segnando in qualche modo una battuta di arresto in questo ciclo infernale.
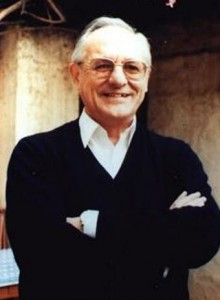 Pierre Claverie, vescovo di Orano, assassinato il 1 agosto 1996. Un bellissimo libro pubblicato recentemente, scritto da un confratello e amico di Claverie, il Padre Jean-Jacques Pérennès, permette ora a tutti di conoscerlo. Senza attardarsi sulle circostanze della sua morte, l’autore si sofferma a descrivere con sapienza la sua testimonianza, il suo martirio, nel senso profondo del termine, lungo tutta la sua vita di uomo, di religioso e di vescovo. Pierre Claverie era nato ad Algeri, nel quartiere Bab el-Oued, nel 1938, dove trascorse anche tutta la sua infanzia e l’adolescenza. Dopo vari anni di studio e di formazione in Europa come Domenicano, fece ritorno in Algeria, dove rimase fino alla morte. Dopo essere stato per vari anni direttore del “Centre des Glycines”, divenne vescovo di Oran nel 1981. Uno dei capitoli del libro di Pérennès reca il titolo “Verso l’incontro gioioso con l’Altro”. Infatti, una dimensione importante del cammino di Claverie è stata la graduale scoperta dell’Altro. Non si trattava tuttavia di una semplice scoperta, ma dell’accettazione dell’Altro in tutta la sua differenza.
Pierre Claverie, vescovo di Orano, assassinato il 1 agosto 1996. Un bellissimo libro pubblicato recentemente, scritto da un confratello e amico di Claverie, il Padre Jean-Jacques Pérennès, permette ora a tutti di conoscerlo. Senza attardarsi sulle circostanze della sua morte, l’autore si sofferma a descrivere con sapienza la sua testimonianza, il suo martirio, nel senso profondo del termine, lungo tutta la sua vita di uomo, di religioso e di vescovo. Pierre Claverie era nato ad Algeri, nel quartiere Bab el-Oued, nel 1938, dove trascorse anche tutta la sua infanzia e l’adolescenza. Dopo vari anni di studio e di formazione in Europa come Domenicano, fece ritorno in Algeria, dove rimase fino alla morte. Dopo essere stato per vari anni direttore del “Centre des Glycines”, divenne vescovo di Oran nel 1981. Uno dei capitoli del libro di Pérennès reca il titolo “Verso l’incontro gioioso con l’Altro”. Infatti, una dimensione importante del cammino di Claverie è stata la graduale scoperta dell’Altro. Non si trattava tuttavia di una semplice scoperta, ma dell’accettazione dell’Altro in tutta la sua differenza.
A partire dal capovolgimento politico del 1988 e soprattutto dopo gli eventi tragici del 1992, egli non cessa di affermare la necessità di “vivere insieme nel rispetto delle differenze”. Con gli amici algerini che condividono il suo stesso modo di vedere, non cessa di analizzare le situazioni che si succedono e di applicare questo principio del rispetto della differenza. Alcuni lo accusano di “fare politica”. In realtà, ciò che egli fa è piuttosto un’analisi seria della situazione politica per dare ad essa una risposta cristiana. La comprensione che egli ha della situazione lo porta a denunciare costantemente in nome del Vangelo tutte le ingiustizie e tutte le violenze. Il 15 agosto 1993 pubblica un comunicato sulla stampa algerina, con il titolo «Non possiamo tacere », da cui cito alcuni passaggi:
“Con i cattolici della mia diocesi, vorrei dire la costernazione e l’orrore che ci assalgono davanti alla spirale di violenza in questo paese che noi amiamo … Preghiamo Dio di illuminare con la sua sapienza coloro che oggi detengono il potere e coloro che lo combattono con la violenza, perché il dialogo e la pace permettano di risolvere, nella giustizia, i problemi davanti ai quali si trova il popolo algerino, con un’attenzione particolare per coloro che sono più duramente colpiti dalla crisi economica. Facciamo umilmente appello alla ragione e alla fede di tutti i credenti, perché il dialogo prenda il posto dell’omicidio e della repressione.”
Fu, appunto, la sua risposta evangelica alla situazione di violenza che gli meritò la morte. Pierre Claverie non è morto da solo. La stessa bomba omicida che lo fece a pezzi trascinava nella morte un Musulmano, il suo autista ed amico Mohammed, mescolando il loro sangue sul paviment.. Si è spesso sottolineato il carattere altamente simbolico di questa unione nella morte. Questa circostanza ci ricorda che la morte dei testimoni cristiani in Algeria non può essere separata da quella di tutte le altre vittime della stessa spirale di violenza che travolge questo paese da circa dieci anni. Pur nella mancanza di dati ufficiali, si può valutare a circa duecentomila il numero delle vittime, in maggioranza anonime. Indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa o politica, queste persone sono state eliminate, almeno in un buon numero di casi, per aver incarnato nella loro vita, anch’esse, gli stessi valori che i cristiani incarnavano per la loro fedeltà a Cristo: il rispetto della differenza, fondamento dell’accettazione e dell’amore dell’altro in quanto altro. Come si è detto prima, tutti sono in qualche modo martiri.
I sette monaci di Tibhirine Vorrei ora soffermarmi sulla descrizione della testimonianza cristiana (il marturion) dei sette monaci di Tibhirine, assassinati verso il 21 maggio 1996. Non si tratta di sette testimonianze date individualmente, benché ciascuno di essi avesse una forte personalità. Si tratta della testimonianza di una comunità. È dunque importante conoscere bene come questa comunità fosse radicata nella società algerina, e per questo bisogna risalire un po’ indietro nella storia.
Molti decenni prima, era esistita una prima comunità cistercense a Staouëli, a 17 chilometri ad ovest di Algeri. Fondata dall’Abbazia di Aiguebelle nel 1843, tredici anni dopo la conquista dell’Algeria, aveva raggiunto una certa notorietà per il suo rapido sviluppo. Questa fondazione era tuttavia molto integrata nel sistema coloniale, sia nello spirito che nelle modalità di insediamento. Venne soppressa nel 1904. Una nuova comunità, con uno stile e uno spirito molto diversi, veniva fondata vicino a Medea circa 35 anni dopo.
Come molti monasteri sorti nel XIX secolo o agli inizi del XX, la comunità di Notre-Dame de l’Atlas, era stata fondata per servire da rifugio. Un gruppo di monaci del Monastero di Notre-Dame de la Délivrance in Slovenia, temendo l’espulsione, avevano aperto un rifugio a Ouled-Trift nel 1934, che in seguito venne trasferito a Ben Chicao nel 1935 e, nel 1938, a Tibhirine, a 7 chilometri da Medea. Lo stesso rifugio venne poi assunto dall’abbazia francese di Aiguebelle e trasformato in fondazione vera e propria, che ben presto divenne una comunità monastica autonoma. Fin dagli inizi, questa comunità instaurò delle relazioni di amicizia e di collaborazione con la popolazione locale che, in qualche modo, la adottò. I legami creatisi con la popolazione locale permisero alla comunità, benché composta totalmente da francesi, di attraversare senza difficoltà eccessive la guerra di Algeria. Uno di essi, Fr. Luc, venne si catturato come ostaggio, ma fu liberato qualche giorno dopo.
Alla fine della guerra di Algeria la situazione era, in ogni modo, radicalmente cambiata. La Chiesa di Algeria, composta in gran parte da francesi o da “pieds-noirs”, francesi nati in Algeria, si ridusse a un piccolo resto, a causa dell’esodo massiccio di entrambi i gruppi verso la Francia. Le conversioni al cristianesimo erano divenute pressoché impossibili – almeno le conversioni riconosciute apertamente. Esclusa la possibilità di un reclutamento locale, ci si poteva interrogare sull’opportunità di mantenere in Algeria una comunità ormai molto ridotta di numero e che non aveva più la possibilità di trovare reclutamento sul posto. Le autorità dell’Ordine cistercense decisero quindi la soppressione del monastero. Ma il Cardinale Duval, che da tempo aveva riconosciuto nella comunità di Tibhirine una realizzazione del suo ideale di presenza cristiana, ruggì come un leone, e il monastero non venne chiuso. La semplice presenza di una comunità monastica cristiana, quale che fosse la nazionalità dei suoi membri, gli sembrava di importanza capitale. La comunità continuò a sussistere e la sua testimonianza fiorì nella morte di sette dei suoi membri, nel 1996. Tutta la popolazione locale, interamente mussulmana, pianse unanime la loro morte.
Esaminiamo ora, brevemente, la natura della testimonianza di questi monaci. Fu una testimonianza di comunione (la realtà cristiana per eccellenza, poiché “Dio è comunione”, come dice San Giovanni) a vari livelli.
1. Comunione con Dio nella preghiera contemplativa
2. Comunione tra i fratelli dentro una comunità
3. Comunione di questa comunità con i vicini
4.Comunione di credenti con altri credenti
1. Comunione con Dio nella preghiera contemplativa
Il monaco viene al monastero per servire Dio, vivendo anche, il più profondamente possibile, nell’ambito del chiostro monastico, l’unione personale con Dio a cui ogni essere umano è chiamato. Figlio nel Figlio Primogenito, mosso dall’amore effuso nel suo cuore dallo Spirito Santo, si sforza di incontrare il Padre in una preghiera che vuole essere, nella misura del possibile, continua e che si esprime visibilmente nella celebrazione della liturgia. Tutta la sua vita tende all’unione mistica, che consiste nel lasciarsi trasformare, un giorno dopo l’altro, a immagine di Cristo dall’azione dello Spirito Santo. Il modo in cui ciascuno dei sette fratelli visse nel profondo del cuore questa unione mistica, fa parte del segreto di Dio. Eppure uno di essi, ricco di talenti poetici e mistico nello spirito, ci ha permesso di intravedere nei sui scritti questo dialogo interiore. Si tratta di Christophe. Le sue poesie, ma soprattutto il suo diario degli ultimi anni dimostrano come tutti gli avvenimenti quotidiani, in questi tre anni intensi per i loro eventi drammatici, e tutto attorno ad essi si trasformava in preghiera e in una occasione per lasciar sgorgare l’intensità dell’amore. Questo diario è un lungo poema d’amore, incarnato in una situazione estremamente concreta ed è opportuno citarne almeno qualche passo:
“O, se morire potesse arrestare ed impedire la morte di tanti altri ancora, o, allora, volentieri, come si dice volentieri: sì, mi offro come volontario.” (20/12/1994).
“Ti chiedo quest’oggi la grazia di diventare servo / e di donare la mia vita / qui / come riscatto per la pace / come riscatto per la vita / Gesù attirami / nella tua gioia / d’amore crocifisso” (25/07/1995).
2. Comunione tra fratelli dentro una comunità.
Questi fratelli non hanno vissuto la loro relazione mistica con Dio come individui isolati, ma come comunità. La loro è stata una testimonianza comunitaria – la testimonianza di una comunità che contava, oltre ai sette fratelli messi a morte, altri due che sono sfuggiti al sequestro e all’esecuzione, ed altri che vivevano in quel momento nella casa annessa di Tibhirine in Marocco.
Era un’autentica comunità cristiana: non la riunione di amici che si riuniscono per delle affinità particolari o per il fatto di condividere le stesse idee e gli stessi progetti. No, una comunità cristiana è formata da un gruppo di persone, di solito molto diverse le une dalle altre sotto tutti i punti di vista, e che Dio ha riunito per farne il sacramento della sua presenza. Ogni membro di questa comunità di Tibhirine aveva una propria storia personale e un percorso vocazionale molto caratteristico; ciascuno aveva una personalità ben definita, così diversa l’uno dall’altro quanto si possa pensare. E tuttavia erano giunti, soprattutto durante gli ultimi tre anni, non solo a vivere una comunione molto profonda tra di loro, ma anche una perfetta unanimità nelle decisioni per cui ne andava della loro vita – una unanimità che non poteva essere radicata se non nella profonda vita di preghiera di ciascuno di loro.
Bruno, figlio di un militare che aveva prestato servizio in Algeria; Celestin, già educatore di gente di strada e Paul, idraulico e ex-prefetto in Alta Savoia: ciascuno apportava alla comunità una grande ricchezza di dono di sé e di spirito comunitario.
 3. Comunione di questa comunità con i vicini.
3. Comunione di questa comunità con i vicini.
Tra questi monaci, molto semplici, e la gente che li circondava si erano creati dei legami di amicizia di notevole profondità. E fino ad oggi, a più di quattro anni di distanza dalla loro morte, questi legami restano ancora vivi, come allora. I legami di amicizia con la popolazione algerina e mussulmana costituiscono senza dubbio una delle espressioni più squisite della loro testimonianza cristiana.
La persona che maggiormente contribuì a creare tali legami fu senz’altro Fr. Luc: varrebbe la pena di scriverne la vita. Nato nel 1914, conobbe ancora bambino le terribili violenze della Prima Guerra Mondiale e le sofferenze del dopoguerra. Giovane medico, conobbe le violenze della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale si fece volontario per portare soccorso ai prigionieri nei campi di concentramento nazisti. Entrato a Aiguebelle nel dicembre del 1941, giungeva in Algeria nel 1946. Subito aprì nella proprietà del monastero un dispensario dove, a partire da quel momento fino alla sua morte nel 1996, – quindi, per cinquant’anni – prestò assistenza medica a chiunque si presentasse a lui, senza fare differenze di nazionalità, appartenenza politica o religione. Tutti lo amavano e lo rispettavano, perché tutti sapevano di essere amati e rispettati da lui. All’inizio, il suo dispensario suppliva l’assistenza medica pubblica, che ancora non c ‘era. Ma se la gente continuò ad andare da lui molto tempo dopo l’installazione di altri dispensari e ospedali pubblici nella regione, è per il fatto che si trovava in lui non solo un toubib, un medico che dava diagnosi quasi sempre esatte ma anche un uomo di Dio, che incarnava nel suo modo d’essere, allo stesso tempo estremamente umano e tutto soprannaturale, la sollecitudine pastorale del Figlio di Dio. Uomo di grande libertà interiore, con senso dell’umorismo realmente disarmante, non aveva paura di nulla e di nessuno. Nessuna minaccia, di qualsiasi provenienza, avrebbe potuto impedirgli di testimoniare fino in fondo, anche a rischio della sua vita, l’amore universale a chiunque avesse avuto bisogno di essere curato.
Anche Christophe, di cui ho già menzionato la dimensione mistica, era, perché poeta, uomo di grande sensibilità. In quanto responsabile degli operai e avendo contatti con la famiglia del custode, in particolare, aveva delle bellissime relazioni di amicizia con tutti. Il suo diario degli ultimi tre anni contiene dei passi di una freschezza straordinaria.
4. Comunione di credenti con altri credenti
Nel momento in cui si consumò la loro testimonianza, Christian era il superiore del gruppo (il priore, come si dice in gergo monastico). La sua vocazione percorse una traiettoria del tutto speciale. Nato in una famiglia di militari, aveva trascorso l’infanzia in Algeria, dove la mamma lo aveva formato a un profondo rispetto dell’Algerino e del Musulmano. Era successivamente tornato in Algeria durante la guerra, come giovane ufficiale. Dapprima prete secolare della diocesi di Parigi, sentì la vocazione alla vita contemplativa e scelse il monastero di Notre-Dame de l’Atlas a Tibhirine. Con il consenso dei superiori, fece a Roma, all’Istituto PISAI, studi di lingua e di cultura araba. Avendo sviluppato una conoscenza abbastanza approfondita e un grande amore per la religione islamica, si investì e investì profondamente la sua comunità nel dialogo inter-religioso. Eletto priore della sua comunità nel 1984, la guidò orientandola più esplicitamente verso quel dialogo inter-religioso, che coronava le altre forme di comunione già praticate. Da diversi anni si riuniva regolarmente al monastero un gruppo denominato Ribât el-Salam, dove si pregava e si condivideva la propria esperienza religiosa.
Nel 1993, quando in Algeria era bloccato il processo elettorale e il paese sprofondava in una spirale di violenza da cui non è ancora riuscito a liberarsi, si intimò agli stranieri di lasciare il paese, sotto pena di venire uccisi. Come molti altri, i monaci di Tibhirine dovettero porsi la questione : bisogna restare o bisogna partire ? Essi scelsero di restare.
Il 14 dicembre dello stesso anno, quando 12 Croati cristiani che lavoravano a Tamesguida, a quattro chilometri dal monastero, furono sgozzati, il problema si presentò in modo più immediato : e ancora di più dopo la visita di un commando armato, nella notte di Natale. Dopo un lungo discernimento nella preghiera, essi scelsero di restare. Nel corso degli anni seguenti, ogni volta che dei missionari – quasi tutti amici intimi della comunità – venivano assassinati, il problema si riproponeva di nuovo con sempre maggiore urgenza. Ogni volta optarono per restare, dopo un profondo discernimento nella preghiera. Perché ?
In Europa, alcuni dicevano che, mentre era comprensibile che dei missionari restassero per continuare il loro « apostolato », non era comprensibile che restassero dei monaci i quali, dopo tutto, avrebbero potuto condurre la loro vita di preghiera in qualsiasi altro posto, altrove … Pensare così equivaleva a non capire niente della loro vita. La vita contemplativa non si vive in astratto. Essa è sempre incarnata, radicata in un luogo e in un contesto culturale ben concreto. I monaci di Tibhirine non desideravano affatto il martirio. Non erano degli esaltati. Se scelsero di restare era per una esigenza di fedeltà, e questo a molti livelli.
Il monaco cistercense fa voto di stabilità. Questo implica non soltanto la stabilità nella vocazione monastica, ma anche la stabilità in una comunità molto concreta e, a meno che non si abbia ricevuto una missione speciale, in un luogo determinato. Certo, tutta una comunità può trasferirsi da un luogo a un altro, ma non lo può fare senza tenere conto dei legami che ha intessuto con la società e la cultura locali. La comunità di Tibhirine non poteva comprendere se stessa se non nelle sue radici nella montagne dell’Atlas, nei suoi legami di amicizia con tutta la gente di Tibhirine, di Draa Esnar, di Médéa. Predicando un ritiro ad Algeri alcune settimane prima del sequestro, padre Christian diceva, con un gioco di parole realmente pericoloso: “ … sottolineo questa differenza : io vengo dalla montagna…”
I fratelli erano consapevoli che anche la popolazione del luogo era stretta come in una morsa tra due violenze opposte, e non poteva scegliere di fuggire. Per i monaci, fuggire, allora, sarebbe stato mancare di solidarietà con coloro dei quali avevano condiviso la vita in tempo di pace. Dopo il martirio di Henri et di Paule-Hélène, Christophe scriveva nel suo diario: “Non si può dimenticare e partire senza tradire ciò che rimane una grazia di prossimità, di amicizia di verità (29/05/1995). I fratelli consideravano la loro presenza come una affermazione del diritto alla differenza – un diritto che reclamavano sia per la gente dei dintorni sia per loro stessi. Mohammed, il custode, aveva detto a Christophe: “Voi avete ancora una piccola porta dalla quale potete andarvene. Ma noi, no : nessuna via, nessuna porta». E Moussa, un operaio, aveva detto a Christian : “Se partite, voi ci private della vostra speranza e ci togliete la nostra speranza”. Non sarebbe stato cristiano partire. E restarono.
Anch’essi, come Pierre Claverie, ma da monaci contemplativi, secondo una modalità diversa da quella del vescovo, analizzavano attentamente la situazione politica del paese: non per reagire come dei politici, ma per dare a questa situazione politica, nella loro vita, una risposta evangelica. “La violenza mi uccide ed io debbo trovare da qualche parte un appoggio, per non lasciarmi travolgere da questo flusso di morte” scriveva Christophe nel suo diario (11/07/1995).
È sufficiente dire che il monaco, soprattutto se straniero, non deve scegliere tra le due forze in conflitto? Ecco la risposta di Christophe: “Forse non basta dire che noi non dobbiamo scegliere tra il potere e i terroristi. In realtà, noi facciamo concretamente, quotidianamente la scelta di coloro che il padre Jean-Pierre chiama ‘la gente comune’ (le petit peuple). Non è possibile restare, se ci stacchiamo da loro. E questo ci fa dipendere – per un verso – da quello che essi scelgono nei nostri confronti. Potremmo cominciare a dare fastidio domani o dopodomani”. In effetti, davano fastidio: diventarono una presenza importuna.
Durante un ritiro predicato ad Algeri, a un gruppo di laici, l’ 8 marzo 1996, Christian commentava con forza il comandamento della Scrittura : “Non uccidere”, applicandolo a tutte le situazioni del paese e terminava con una serie di frasi lapidarie: Non uccidere il tempo … Non uccidere la fiducia … Non uccidere la morte … Non uccidere il paese … Non uccidere il mussulmano … Non uccidere la Chiesa … Due settimane dopo, lui e i suoi fratelli venivano sequestrati e due mesi dopo cadevano vittime di questa violenza.
Quando, nella notte dal 26 al 27 marzo 1996 un gruppo di uomini armati si presentarono al monastero e li condussero via, in direzione di Medea, agli occhi di coloro che li avranno visti attraversare il paese, scortati da uomini armati, avevano l’aria di seguire dei terroristi. In realtà, seguivano Cristo.
Nessuno di loro desiderava il martirio. Essi amavano la vita e temevano la morte. Ma avevano coscientemente ed esplicitamente accettato la morte, se questa fosse stata la volontà di Dio. In una lettera circolare all’Ordine del 21 novembre 1995 avevano scritto : “La morte brutale – di uno di noi o di tutti insieme – non sarebbe che la conseguenza di aver scelto di vivere nella sequela di Cristo.”
Se era necessario morire, volevano morire bene ! Il vecchio fratello Luc, che da tempo aveva chiesto che al suo funerale si cantasse la canzone di Edith Piaff “Non, je ne regrette rien”, il 31 dicembre 1993 – quindi alcuni giorni dopo la drammatica visita della notte di Natale – faceva questa intenzione alla preghiera universale dell’Eucaristia: “Signore, donaci la grazia di morire senza odio nel cuore”.
L’ispirazione di questa bella preghiera è stata ripresa nel Testamento di Christian – un documento molto noto, che resterà senz’altro una delle pagine più belle della letteratura cristiana del XX secolo. Questo testo, d’altronde, non esprime soltanto i sentimenti di Christian, ma quelli di tutti i fratelli. In realtà, a partire da una prima stesura scritta il 1 dicembre 1993, venne terminato il 1 Gennaio 1994. Tra queste due date, Christian lo rielaborò e lo precisò con la partecipazione di tutta la comunità, e questo lo rende un documento che esprime non solo i suoi sentimenti personali, ma quelli di tutti i suoi confratelli.
L’ultimo paragrafo di questo Testamento è molto noto: Christian chiama amico colui che gli avrebbe tagliato la gola: “E anche a te, amico dell’ultimo istante, che non avrai saputo quel che facevi, sì, anche per te voglio questo GRAZIE e questo ad-Dio che tu rifletti nel tuo sguardo. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due.”
C’è tuttavia un altro paragrafo, in mezzo al testo, che ha una profondità mistica ancora maggiore. Alludendo a coloro che lo giudicavano un ingenuo nella sua stima per l’Islam e nella sua volontà di dialogare con i Musulmani, aggiungeva:
“[…] Costoro devono sapere che allora sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i suoi figli dell’Islam come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutto della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e il ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze.”
In questa sublime sintesi, Christian raccoglie insieme la teologia biblica e patristica della ricostituzione della somiglianza divina e la preoccupazione che condivideva con Claverie e che attingeva dal messaggio di Gesù : quella del rispetto delle differenze. Diceva d’altronde poco prima della sua morte che uno dei motivi per restare sul posto, come cristiano ed europeo, era quello di affermare il diritto della «gente comune » del luogo alla propria differenza.
La comunione dei monaci di Tibhirine con il popolo algerino continua oltre la loro morte. Le sette lunghe bare che i cadetti dell’esercito algerino portavano – con apparente sforzo – a Notre Dame d’Afrique il giorno dei funerali, in realtà non contenevano, ciascuna, che una testa. I loro corpi non sono mai stati ritrovati e restano sepolti in modo anonimo nella terra d’Algeria, in un luogo sconosciuto – almeno ufficialmente – come migliaia di altre vittime altrettanto anonime della stessa violenza, contro la quale la loro vita era una protesta evangelica.
Il perdono dato in anticipo da Christian e da tutti i suoi fratelli a coloro che avrebbero potuto ucciderli, come pure il perdono dato dall’Ordine Cistercense e dalla Chiesa d’Algeria al momento dei funerali, non deve essere inteso come una accettazione tacita e tranquilla della violenza, di cui questi testimoni furono le vittime. Questo perdono non dispensa nessuno dal fare luce su tutte le circostanze di questa tragedia. Personalmente, anch’io, per fedeltà alla testimonianza di Christian, Luc, Bruno, Michel, Célestin, Paul e Christophe, voglio perdonare a coloro che li hanno uccisi e a coloro che hanno loro tagliato la testa, ma, pur senza avere l’ardore mistico di Christian, vorrei poter dare un volto a coloro nei quali devo riconoscere l’immagine di Dio.
Con il mirabile testo di Christian, possiamo concludere la nostra presentazione dei martiri d’Algeria. Il momento supremo della loro testimonianza si trova collocato in un periodo estremamente doloroso e confuso della storia dell’Algeria. Un processo di canonizzazione nelle forme previste dal Diritto canonico, presupporrebbe una ricognizione approfondita e minuziosa delle circostanze della morte e delle motivazioni degli aggressori, e si rivelerebbe, allo stato attuale, probabilmente molto difficile. Infatti nessuna inchiesta giudiziaria ha permesso di determinare con certezza né come si sono svolti i fatti, né l’identità degli assassini e dei loro mandanti né ha consentito di dimostrare con certezza in quale misura le motivazioni di questi ultimi fossero esplicitamente religiose. Tutto questo è tuttavia secondario, perché tutti sono stati testimoni (martiri) con la loro vita prima di esserlo con la loro morte; e la loro morte, non c’è dubbio, è stata una conseguenza di ciò che avevano vissuto. Essa è stata provocata da un atteggiamento evangelico in situazioni di violenza percepite lucidamente e analizzate alla luce della fede. Se una lettura puramente politica della loro vita e della loro morte sarebbe manifestamente fuorviante, una lettura puramente spirituale che ignorasse il coraggio e la lucidità con cui essi hanno aderito a situazioni concrete, oltre che essere ingenua, svuoterebbe di senso il loro messaggio. Non fu la stessa cosa per la morte di Cristo?

